Il mi(s)tico mondo dei suoni
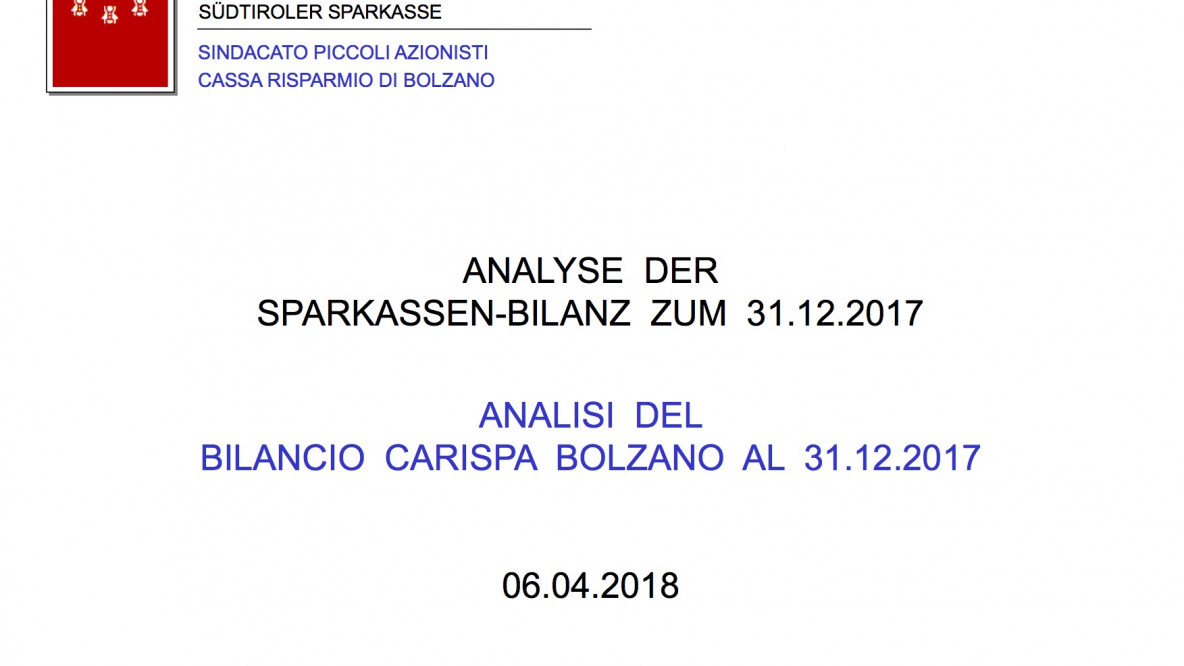
È interessante quanto la musica, se suonata e interpretata con dedizione e passione, possa richiamare nel pubblico che la ascolta visioni simili a quelle che sono capaci di far nascere le parole con il loro significato più determinato e – forse – a noi più familiari in questa funzione. Ne abbiamo avuto un bell’esempio in due serate andate in scena recentemente per il 36esimo südtirol festival merano . meran ideato da Andreas Cappello con il suo sempre molto acuto ingegno artistico: la violinista moldava Patricia Kopatchinskaja assieme al pianista turco Fazil Say e l’attore austriaco Peter Simonischek accompagnato nella lettura di un racconto dal gruppo Die Wiener Salonisten.
I primi due hanno suonato musiche di Franz Schubert (Sonata per violino e pianoforte n. 2 in la minore D 385), Johannes Brahms (Sonata per pianoforte e violino n. 3 in re minore op. 108) e Leoš Janaček (Sonata per violino e pianoforte), ma innanzitutto trascinava il bis concesso a fine concerto tratto dalle “Danze rumene” di Bela Bartok, mentre il secondo ha letto ad alta voce “La leggenda del santo bevitore” dello scrittore austriaco Joseph Roth, intervallato da musiche di Edith Piaf, Erik Satie, Charlie Chaplin, Nino Rota e altri.
Osservare le mani del pianista Fazil Say, che nato nel 1970 ad Ankara aveva iniziato a soli quattro anni (come Mozart) a suonare il piano, e a undici era già iscritto in una scuola di musica per studiare pianoforte, è come osservare una ballerina alle prese di passi complessi di una coreografia di danza: le sue dita corrono sui tasti, li picchettano o li sfiorano per creare quella melodia di base sulla quale interviene la partner di questo duo richiesto dalle varie composizioni: Patricia Kopatchinskaja, già nota al pubblico meranese per essersi esibita più volte al Kursaal con grandi orchestre, col suo violino magico che è stato costruito nel 1834 da Giovanni Francesco Pressenda. Vestita con semplici pantaloni neri e una lunga camicetta di seta blu, le sue mani conducono l’archetto sulle corde del suo strumento a momenti in modo dolce e in altri lo sbatte in aria come a voler simulare a livello corporeo l’intensità delle sonorità che si mescolano con quelle del pianoforte. Allegro, andante, menuetto e trio, allegro, recitano i titoletti della prima sonata, quella di Schubert, mentre quelli della terza - uscita dalla mente del compositore di origine slava Leoš Janaček quando, nel 1914, sopraggiunte le truppe dell’armata sovietica nella Galizia, egli poté persino “sentire lo stridere del metallo delle armi nella sua testa” – dettava “con moto, balada, allegretto e adagio”. Così grazie ai toni “suonati” dalla Kopatchinskaja, la quale qui era “guidata” negli attacchi dalla partitura al piano di Fazil Say e al contempo dalle mani di quest’ultimo per darle la giusta “armonia” nei singoli brani, ci si poteva immaginare quella feroce battaglia armata in un ampio paesaggio, a momenti con tocchi ravvicinati tra un’arma (un suono) metallica (metallico) e l’altra (l’altro). Al più tardi fu il bis che grazie alle tonalità trascinanti delle “danze rumene” di Bartok a risvegliare poi le pacifiche e “allegre” immagini di coppie danzanti nelle feste interminabili dei paesi dell’est, dopo un fiume di unità cicliche nelle musiche da camera composte da Brahms a inizio concerto.
Un duo, Fazil Say e Patricia Kopatchinskaja, che ha già inciso diversi dischi, per cui entrambi hanno ricevuto premi, lei nel 2013 era stata incoronata come “strumentalista dell’anno”, lui ha compiuto nel 2008 il suo primo concerto per violini dal titolo promettente “1001 Nights in the Harem”, la cui prima si era svolta a Lucerna in Svizzera proprio con lei, alla quale la composizione fu dedicata, assieme all’Orchestra sinfonica di Lucerna diretta da John Axelrod. Dal 2016 Fazil Say è “il” nome dell’etichetta Warner, mentre per l’anno di Beethoven, ha inciso le 32 Sonate per pianoforte composte dal musicista tedesco nel corso della sua vita.
Un duo memorabile venuto dall’Est, un duo memorabile cresciuto nel mondo della musica dell’Ovest, un duo memorabile entrato nelle lunghe liste di musicisti che si sono esibiti a Merano al Kursaal raccogliendo un lunghissimo applauso, tanto il pubblico ha voluto esprimere da parte sua la profondità d’animo che hanno raggiunto le loro esibizioni strumentali di partiture composte oltre duecento anni fa essendo riusciti ad attualizzarle con le loro anime contemporanee traghettandole a noi, oggi, nel 2021.
Chi è andato al cinema negli ultimi anni conosce di sicuro il volto e l’anima di Peter Simonischek, l’attore austriaco che interpreta il grullo personaggio principale nel film “Toni Erdmann” della cineasta austrica Maren Ade del 2016. Un uomo strambo che vive ai margini della società e da quella posizione fa riflettere i compagni e le compagne “di gioco” sulla loro vita, quella reale, sentita, e non quella apparente, vissuta superficialmente. Sembra che lo stesso percorso lo faccia intraprendere al pubblico in sala il nostro narratore l’altra sera al protagonista Andreas de “La leggenda del santo bevitore” uscita nel 1934 dalla penna dello scrittore austriaco Joseph Roth. Pare che l’idea fosse nata nel caffè parigino Tournon, allora punto di ritrovo di migranti austriaci di quel periodo storico, quando alcuni amici gli avevano narrato di un clochard passato di lì e che aveva raccontato di dover restituire una somma di denaro in una chiesa. Non potevano che essere le note della “Gymnépodie” n. 1 di Erik Satie, composta nel 1888, a farci immaginare gli scalini che bisogna scendere per raggiungere le passeggiate sulle rive della Seine nella capitale francese, creando il giusto ambiente per accompagnare mentalmente il clochard Andreas, col suo giornale sotto braccio, fino a uno dei ponti, dove avrebbe passato la notte coperto dalle pagine di quel quotidiano che scaldano quanto una coperta di lana.
Qualche ora prima un signore borghese gli aveva regalato 200 franchi francesi e questa famosa melodia di Satie ci ha immerso decisamente meglio nelle atmosfere parigine del precedente song che aveva dato il “la” alla serata, “Padam padam” di Edith Piaf. Come mai? Forse perché Satie racchiude nelle note quel tocco parigino che la Piaf poteva dare con la sua voce, ma venendo a mancare quella voce tipicamente roca nell’esecuzione puramente strumentale era venuta meno, a mio avviso, l’atmosfera che doveva trasmettere. In ogni caso quella sera nel quasi pieno Kursaal è stata la voce umana narrante a fare da protagonista, è stata la voce di Simonischeck a guidarci nel regno dell’immaginario, le musiche hanno fatto unicamente da sfondo e da corollario scenico dove ci voleva. Come ad esempio sono state le parole a farci immaginare la taverna in cui lo specchio della parete fece scoprire ad Andreas la propria depravazione, un esempio sfavillante di come lo stile narrativo di Roth possa con pochi ma precisi dettagli creare una scena che trasferita al cinema avrebbe dovuto essere completamente ricostruita dallo scenografo grazie ad arredi complessi. Così come con pochi elementi descrive la scena in cui a noi, che ascoltiamo, apre il mondo femminile in cui vagava il nostro Andreas: un abitino nero, stretto e austero, un bustino bianco davanti, capelli ricci e un grosso bracciale d’oro.
La sineddoche compone il tutto: è da questi pochi dettagli che siamo in grado di creare nella nostra mente l’immagine dello stesso uomo e di ciò che lui immagina, nonché il passar delle sue giornate, di cosa e come lo vive: una scala, le gambe, i polpacci, la voglia di amore che sale, la taverna, le ragazze, la lunga dormita nella camera, il lavoro per un trasloco, e finalmente una lunga dormita ristoratrice in un hotel. Appare decisamente cinematografica la scrittura rothiana, e fa venire in mente l’adattamento per il grande schermo di quel racconto da parte di Ermanno Olmi, con il quale il regista italiano vinse il Leone d’oro a Venezia nel 1988.
L’intervallo musicale numero tre ci ha rimandato a Chaplin, alle sue musiche, ai suoi personaggi, desolati ma sempre gustosamente umani: infatti, Roth afferma che Andreas bevve molto ma non si ubriacò mai.
Entrato in un locale di ballo con la sua Caroline ritrovata per caso, la donna per cui aveva dovuto passare un paio di anni in carcere, nel mentre volle restituire il prestito dell’uomo borghese alla piccola santa Teresa nella sua chiesetta in una piazza a Parigi, la musica “Quel temps fait-il à Paris” di Alan Romans è risuonata sullo sfondo, mentre la voce narrante continuava a risuonare finché esclamando che era “come ai tempi prima della prigione” ci rendeva partecipe della presa di coscienza del destino in Andreas, del suo “Mantel der Zeiten”, di quel periodo della sua vita che lo aveva riaccalappiato e dal quale lui scappò. Immediatamente. Prendendo il volo. Per andare alla ricerca di altri miracoli che dovevano pur avvenire in un periodo tanto miracoloso…
Difatti nell’albergo in cui il suo amico Kanjak, ormai calciatore famoso, gli aveva affittato una camera per poter recapitargli un paio di abiti che gli volle regalare essendo Andreas vestito con abiti consumati non adatti allo status di uomo ricco (perché aveva poco prima trovato un biglietto da 1000 franchi in un portafoglio consegnatogli da un poliziotto che credeva fosse caduto dalla sua tasca, quale uomo rispettoso - ormai - dalla barba rasata e dal capello tagliato era), camminando lungo il corridoio alla ricerca della sua camera numero 89, il rinnovato Andreas fuggito dalla “sua” Caroline perché ormai invecchiata incontra una donna, giovane, bellissima, che non poteva non andare a trovare quella stessa sera, di nome Gabi. Lo aveva mai sentito quel nome? Certamente, disse Andreas, lo conosceva dai giornali, ma non aggiunse quel pensiero sorto immediatamente, ossia da quei giornali con i quali lui si copriva per vincere il freddo…
Le vicende miracolose di Andreas non potevano durare in eterno e Joseph Roth trovò soluzioni affascinanti per condurre il suo personaggio in un mondo favoloso che tuttavia si poteva ben sposare con una certa realtà di quegli anni di tarda avanguardia sperimentale in voga nella Parigi dei primi anni trenta, pochi anni soltanto prima dell’invasione nazista che sarebbe avvenuta nemmeno dieci anni dopo, a inizio degli anni quaranta del Novecento: fa apparire una fanciulla vestita di blu, quel blu cielo, che già anticipa il finale che presto sarebbe avvenuto, la bella morte di Andreas nel mezzo del bar in cui attendeva di andare nella chiesetta per portare i 200 franchi francesi che gli erano rimasti nel taschino alla santa Teresa…
Uomini e miracoli, povertà e dignità, rispetto e amore, amicizia e aiuto reciproco, sono soltanto alcuni dei valori propagati da Roth nella sua “leggenda” e che Cappello ha fatto bene a far risuonare nelle ampiezze del Kursaal, in un certo senso anche “cuore pulsante della città di Merano” in questi giorni che sta andando incontro alle prossime elezioni comunali…
E per continuare nella metafora diciamo che gli ultimi due concerti portano davanti agli occhi come un “vero” consiglio comunale dovrebbe agire: al pari di un’orchestra diretta da un abile direttore d’orchestra che sappia animare con dedizione e convinzione un gruppo di persone grazie ai movimenti e l’espressività della sua bacchetta (“magica”?) proprio perché tutti sanno riconoscere quell’input ai fini di suonare armoniosamente insieme. Dove – lo ricordiamo – “armonia” non vuol dire “unisono” bensì in un modo in cui ogni strumento rispetti la sonorità dell’altro affinché ognuno possa far sentire la propria sonorità (e la propria voce) nell’insieme. Un esempio? La Mahler Chamber Orchestra con ospite al pianoforte Yuia Wang, con musiche di Haydn, Bach e Shostakovich.
Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.