Narrazioni migranti: scenari nuovi e prospettiva di convivenza
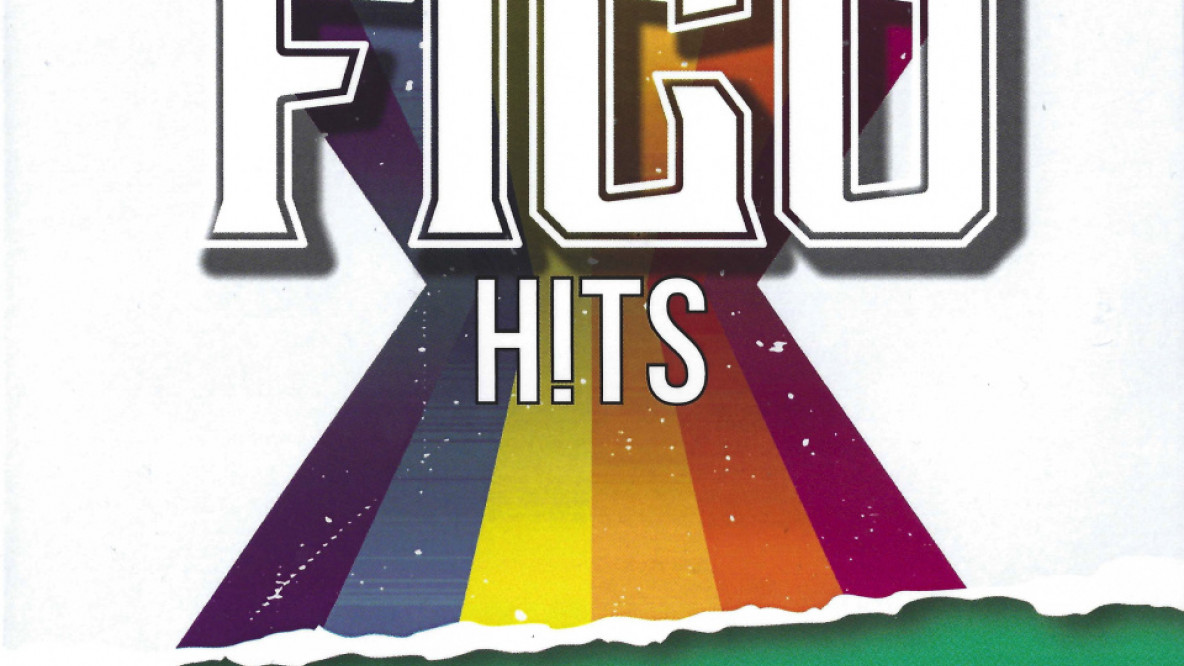
Una mattina, alle prime luci dell’alba, in una città in cui mi trovavo di passaggio, affacciandomi alla finestra mi trovai di fronte una bellissima palma, pianta caratteristica del paese dove ho trascorso la mia infanzia. Questo mi fece pensare che anche una palma è un simbolo interculturale; infatti i viaggiatori inglesi, che giravano il mondo, importarono le palme che oggi abbelliscono il lungomare di diverse località della penisola italiana. Dunque quando mi chiedono che cosa è “intercultura”, dico che basta seguire i passaggi degli esseri umani su questa terra, che hanno conosciuto e accolto simboli di altre civiltà. Si può parlare d’intercultura anche partendo da tracce molto reali, concrete, che troviamo quotidianamente nel nostro spazio ambiente.
Spesso tuttavia, trattando il tema dell’intercultura in situazioni d’immigrazione, ci si dimentica che alla base di questo processo ci sono persone che abbandonano il loro paese d’origine, con un desiderio di emancipazione sociale. La gente va dove crede di trovare maggiori opportunità.
E' ormai celebre la frase di un migrante italiano negli Stati Uniti: «Sono venuto in America perché mi avevano detto che le strade erano lastricate d'oro. Quando sono arrivato ho scoperto tre cose: Primo, che le strade non sono lastricate d'oro; secondo, che le strade non sono lastricate affatto; terzo, che dovevo lastricarle io.»
Come dice Franco Cassano, sociologo dell'Università di Bari, per i migranti di ogni latitudine che hanno abbandonato il proprio paese pensando di trovare la terra promessa, nella realtà concreta la terra promessa si rivela piena di ostacoli, difficoltà, fatiche, umiliazioni e marginalità.
Queste riflessioni le troviamo anche nelle parole di Edoardo Galeano, che descrive l'esperienza degli immigrati giunti a Ellis Island negli Stati Uniti: «I custodi della terra promessa classificavano gli immigrati, auscultavano il cuore e i polmoni, studiavano le palpebre e i piedi, misuravano l'intelligenza. I neo arrivati non sapevano né leggere né scrivere e parlavano una lingua a loro sconosciuta. Per misurare il quoziente di intelligenza delle donne chiedevano come si spazzavano le scale: si spazzavano verso l'alto, verso il basso o verso i bordi? Una ragazza polacca rispose: io non sono venuta in questa terra per spazzare le scale».
La donna citata nel testo di Galeano è vissuta circa un secolo fa, ma la condizione per le donne non è cambiata: ci sono sempre le logiche funzionali proprie del mercato del lavoro che ha bisogno di persone che “facciano delle cose”, con rivendicazioni minime ed un salario minimo.
Dice una donna peruviana, oggi in Italia, in riferimento alle donne immigrate: “Non è il clima, non è la latitudine, non è l'inquinamento ma c'è qualcosa che vi divora ogni momento, c'è che siete sole e avete paura di non farcela. Se rimanete senza lavoro vi cade in testa tutto quello che avete costruito fino a qui. La domanda che mi tormenta è: Ma fino a quando? Gli anziani non durano in eterno, quando è finita per loro è finita anche per voi e allora si va a stirare, lavare pavimenti tanto che un giorno vostro figlio vi dirà: per fortuna che oggi sei malata, mamma, così resti a casa con noi”.
Di fronte a vissuti e testimonianze di questa natura, si comprende come parole quali “identità” e “cultura” possano essere fuorvianti qualora usate nei confronti dei migranti, poiché si rischia di occultare la condizione sociale in cui si trovano a vivere.
Oggi, chi sono queste persone che vengono in Italia? Sono immigrati, questo è un elemento fondante della loro identità. La cultura, spesso e volentieri, migra al di là del confine statuale. L'intercultura si basa su un concetto di contiguità: gli altri non sono "diversi" in modo assoluto.
Sulla base di una concezione di cultura come processo dinamico in contesto migratorio, si sviluppa quello che possiamo chiamare strategia di mediazione socioculturale, perché parte dalla condizione sociale dell'immigrato e non da un’astratta concezione identitaria riferita alla cultura di provenienza.
La relazione paritaria è fondamentale per creare una convivenza plurale. Cosa che certamente oggi non c'è.
Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.