La Germania sì che ha fatto i conti
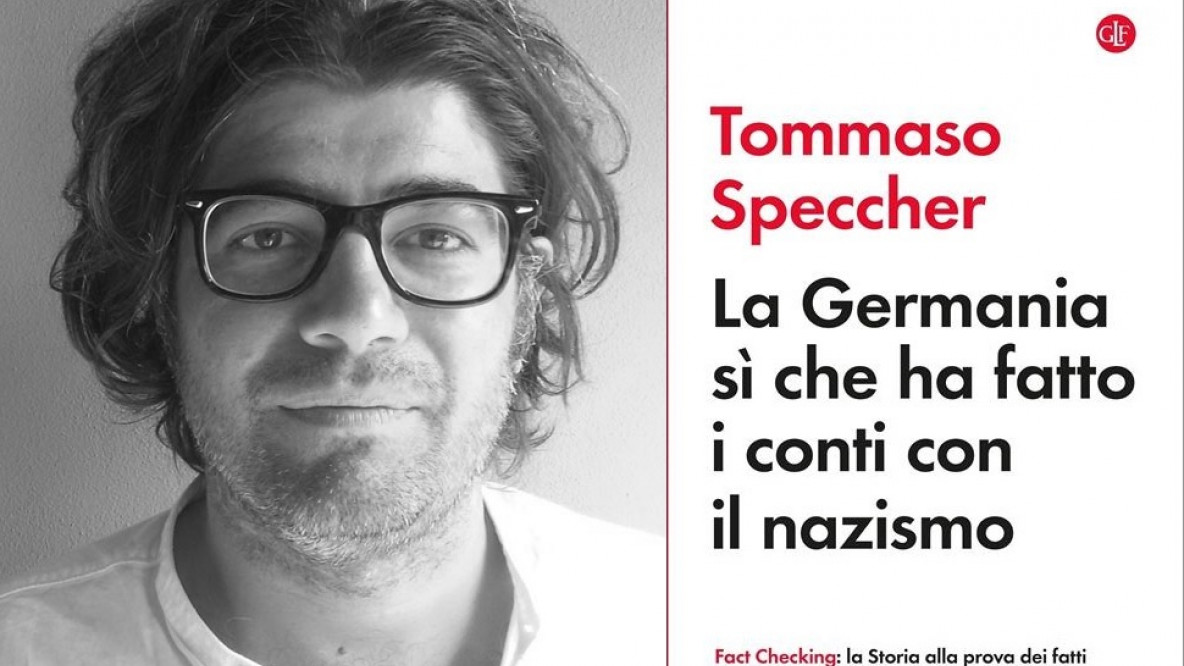
-
„Nel discorso pubblico italiano e internazionale c‚è una formula che ritorna costantemente: “la Germania ha saputo fare i conti con il nazismo„. Se però andiamo a verificare quanto c‘è di vero in questa frase, ci accorgiamo quanto il passato nazista abbia condizionato il lungo dopoguerra tedesco, generando una tacita e continua tensione, ma producendo solo occasionalmente effettive prese di responsabilità. In questo libro scopriremo come, dopo decenni di oblio e di silenzio interessato, si è cominciato ad affrontare questo tema. Soprattutto dopo la riunificazione del 1990, quando la rielaborazione dei crimini nazisti si fa strumento di unità politica e collettiva. Il periodo della Guerra fredda, invece, si distingue per la mancata riflessione sul passato; un passato sospeso, spesso rinnegato. Partendo dalle rovine della Germania post-bellica, passando per i movimenti studenteschi del ʼ68 e arrivando ai memoriali odierni, queste pagine raccontano biografie chiave, vicende emblematiche e dibattiti esemplari. E mostrano che “i conti„ sono stati fatti, sì, ma solo in parte e, forse, troppo tardi.“
Quella che precede è la sinossi del libro „La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo“. Per descriverne in estrema sintesi il contenuto giova rifarsi alle motivazioni della commissione giudicatrice del premio letterario „Roberto Visintin“ citato nel sottotitolo:
„Il libro di Tommaso Speccher, ripercorrendo in chiave storica il periodo successivo alla Seconda guerra mondiale in Germania, evidenzia molti temi decisivi non soltanto per quella Nazione liberata dal nazismo, ma per tutti i popoli e per ogni persona. Emblematicamente, la grande e per certi versi finora poco sottolineata fatica dimostrata dai tedeschi nel “fare i conti con la storia„, pone problemi che trascendono quei particolari tempi e spazi. La questione della giustizia si intreccia con quella fondamentale della colpa, così come la condanna si coniuga singolarmente con il decisivo tema della memoria. Speccher, con un linguaggio semplice e con una formidabile preparazione storico scientifica, accompagna il lettore in un viaggio che suscita indignazione e ammirazione, inquietudine e rimorso, interesse e passione. In ogni caso, il volume spazza via i pregiudizi e le frasi fatte. Non si tratta di “aver fatto i conti con il nazismo„, ma di identificare un lungo processo di trasformazione, costituito da slanci in avanti e ricadute nel passato, là dove la questione della qualità del ricordo rimane aperta maggiormente a nuovi interrogativi piuttosto che a risposte definitive“
Luca Marcon
Dottor Speccher, caro Tommaso, nel rinnovarti i complimenti per il tuo saggio che ti ho fatto di persona vorrei attirare la tua attenzione su alcune parti del libro che mi hanno particolarmente colpito.
Per prima, la questione del mito della Wehrmacht „pulita“ opposto alle „cattive“ SS quali vere e uniche responsabili delle azioni criminali e soprattutto genocidarie del regime nazista.Tommaso Speccher
Quello delle responsabilità dell’esercito tedesco nell’evoluzione della Shoah fu uno dei grandi temi repressi o sospesi dal dibattito pubblico nella „Prima Germania“, fino al 1989. La mancata dichiarazione della Wehrmacht in quanto „organizzazione criminale“ - al pari appunto delle forze di Polizia (SS e Gestapo) e del partito nazista (NSDAP) - da parte delle corti di Norimberga generò una sorta di discolpa collettiva che andò ben oltre i soldati dell’esercito, riguardando la società intera.
Tra il 1929 e il 1945 erano stati infatti quasi 18 milioni i soldati di ruolo e un giudizio sulla Wehrmacht non poteva che combaciare con un giudizio sulla società intera. Gli alleati non potevano permettersi di ripetere gli errori compiuti alla fine della Prima guerra mondiale con la Pace di Versailles, che aveva sostanzialmente condannato l’intero popolo come „unico responsabile di tutti i crimini, danni e devastazioni della guerra“. Indicare la Wehrmacht come organizzazione criminale avrebbe sostanzialmente significato la messa sotto accusa della società intera, cosa non voluta dall’alleato americano. In particolare, i due pubblici ministeri dei processi di Norimberga Jackson e Taylor avevano ben chiaro quanto fosse necessario distinguere le responsabilità nella loro complessità e quindi specificità decisionale e di potere. Se è vero che nelle varie conferenze tenute dagli alleati prima della fine della guerra si erano indicati i „quattro pilastri organizzativi“ dei crimini nazisti - partito, le forze di polizia, l’esercito e la grande industria - quello a cui si assistette ai processi di Norimberga fu di fatto un progressivo svuotarsi delle responsabilità generali dell’esercito e dell’industria e la proclamazione delle forze di Polizia e del Partito come organizzazioni criminali principali. Questo meccanismo di allentamento è da alcuni ricondotto alla contemporanea ed evidente emersione delle tensioni dell’imminente Guerra fredda; per gli alleati occidentali si poneva come indispensabile il mantenimento in prospettiva di una forza di difesa, per lo meno formale, nella Germania post-bellica. La nascita della Bundeswehr del 1955 fu il risultato di questi interessi e scelte.Veniamo ora ad Hannah Arendt e alla sua analisi del „Processo Eichmann“. Nella „Banalità del male“ la filosofa già allieva di Heidegger ne traccia una figura a guisa di un banale servitore del regime hitleriano, un piccolo, grigio burocrate appena consapevole degli effetti delle sue azioni.
I lavori successivi, tra tutti quello di Bettina Stangneth, rovesciano completamente questo paradigma riconoscendo a Eichmann la volontà cosciente e determinata di compiere i crimini per i quali viene condannato in Israele alla pena capitale nel 1963.
Come è possibile che Arendt, forse una delle intellettuali più lucide sul tema, sia potuta incorrere in un errore di valutazione di questa portata?Le riflessioni di Hannah Arendt sono un passaggio indispensabile per poter rapportarsi alla complessità della Shoah e agli aspetti di ordine politico, sociale e filosofico ad essa connessi.
Rimane il fatto che Hannah Arendt era una donna del suo tempo, un’era ancora forse troppo vicina a quei crimini efferati ma soprattutto segnata da una scarsezza nella rielaborazione documentale e archivistica. Arendt era alla ricerca di una teoria generale dentro cui spiegare il fenomeno delle violenze naziste, da fare rientrare in una teoria filosofica generale. Quello che non poteva comprendere era la peculiarità e specificità di quei crimini, compiuti all’interno di un sistema criminale perpetrato da migliaia di approfittatori, uomini in carriera, specialisti del genocidio, le cui carriere ci danno al giorno d’oggi l’immagine di quanto ognuno avesse in realtà un ruolo indispensabile, implementato e voluto all’interno della Shoah. Oltretutto le teorie complessive come quelle della Arendt hanno purtroppo segnato negativamente la prima generazione di studiosi e ricercatori, se non del pubblico generale, dando forma ad una sorta di „inevitabilità dei crimini“, come se altro non fosse stato possibile e come se in qualche modo nessuno ne fosse in realtà stato responsabile. Quello a cui le ricerche degli ultimi vent’anni ci hanno messo davanti è invece un sistema di crimini, risultanti da scelte politiche, strategiche, spesso anche economiche, dietro cui si nascondevano interessi carrieristici e personali, assolutamente non inevitabili ma voluti e in un quadro di consapevolezza organizzativa. La stessa „testimonianza“ di Eichmann a Gerusalemme fu in realtà risultato di una specifica scelta difensiva dell’imputato, il cui profilo di criminale consapevole era ben diverso da quel „burocrate passivo“, emergente dalle pagine della Banalità del male. Ma d’altronde fu solo a partire dagli anni ‚90, quando emersero le registrazioni delle interviste fatte da Willem Sassen che si svelerà il vero volto di Eichmann stesso, criminale e approfittatore seriale.Nel 1996 viene pubblicato in Germania „Hitler’s Willing Executioners“ („I volonterosi carnefici di Hitler“) dello storico Daniel Jonah Goldhagen, nel quale secondo l’autore, cito dal tuo libro, „furono le convinzioni antisemite dei tedeschi la causa principale dell’Olocausto“.
Al riguardo hai evidenziato il „carattere pregiudiziale, se non razzista“ di questa tesi„. Il lavoro di Goldhagen, però, non è un unicum ma la naturale prosecuzione degli studi che lo hanno preceduto: tra tutti, “Le origini culturali del Terzo Reich„ di George L. Mosse, ma anche i lavori di Carl G. Jung sulla “Bionda bestia„ del 1918 o il saggio “Wotan„ del 1936.
Richiamando la famosa affermazione di Max Weber laddove “sono i valori che intenzionano le azioni„, rimani sempre della tua opinione?Credo che il mestiere dello storico e innanzitutto del divulgatore sia quello di rimettere assieme i fatti partendo dalle evidenze. Il giudizio su questi fatti si definisce poi in secondo luogo. Evidente è che il potere nazista, esercitato in nome di un fantomatico “popolo tedesco„ se la prese indistintamente con chiunque non corrispondesse alla sua idea di società o di chiunque non si sottomettesse a quel modello. In nome di questa prassi sin da subito verranno condotti nei campi decine e poi centinaia di migliaia di tedeschi. Ebrei, omosessuali, Sinti, persone non autosufficienti finiti nell’operazione T4, tutta gente perseguitata e portata nei campi sin dal marzo 1933 erano tedeschi, era un pezzo di società tedesca, erano semplicemente cittadini tedeschi. Goldhagen, partendo anche da una storia personale e famigliare ha dato vita ad una lettura sostanzialmente rancorosa e generalista del “tedesco„ nazista e criminale, formulando il principio di un antisemitismo sterminatorio alla base della cultura tedesca moderna. Ma la popolazione ebraica, assieme agli altri due milioni di “tedeschi„ finiti nei campi di concentramento erano loro stessi parte di quella cultura. Il romanticismo stesso è figlio di una dialettica storica di Illuminismo e Sturm und Drang, in cui importante fu il contributo ebraico, penso qui a Moses Mendelssohn o Heinrich Heine. Certo la lettura di una cultura tedesca innatamente o genealogicamente sterminatoria ha il suo fascino epistemologico ma non sta in piedi. Altra cosa è ricostruire l’origine ideologica della morale nazista che è figlia anche certo di pezzi tradizione teutonica ma molto più devastante e significativa è la strumentalizzazione politica di quel riferimento. E vorrei qui citare proprio Hannah Arendt che nella sua intervista a Gaus disse semplicemente di come i nazisti fossero “una banda di gente senza scrupoli„ che usò la propaganda e la miseria collettiva come strumento di raggiungimento del potere assoluto.
Il tuo libro si occupa della Germania. Ma c‘è un altro paese dell’area germanofona il cui coinvolgimento nel regime hitleriano è stato invece inizialmente elaborato attraverso un approccio per così dire originale.
Mi riferisco all’Austria e cito tra i tanti esempi lo scandalo Kurt Waldheim o la polemica che vide su fronti opposti il primo ministro Bruno Kreisky e Simon Wiesenthal, il “cacciatore di nazisti„ laddove il primo rinfacciò al secondo di essere un “Nestbeschmutzer„ (“uno che sporca il proprio nido„) dopo che Wiesenthal lo aveva accusato di aver formato un governo composto anche da ministri compromessi con il terzo Reich.Le modalità di rielaborazione del passato nazista da parte dell’Austria si differenziano significativamente da quelle della Germania proprio per l’adozione della cosiddetta tesi della prima vittima (Opferthese). Lo storico viennese Karl Stuhlpfarrer, profondo conoscitore delle vicende austriache che vanno dall’annessione del 1938 (Anschluß) al 1991, anno nel quale l’allora cancelliere federale Franz Vranitzky afferma pubblicamente le corresponsabilità del suo paese nel regime hitleriano, si esprime nei termini di un vero e proprio mito fondativo.
Anche se tutti concordano nell’identificare il punto di genesi nella cosiddetta “Dichiarazione di Mosca„ del 30 ottobre 1943 redatta congiuntamente dai ministri degli esteri di Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, dove si afferma che l’Austria “il primo paese libero, che dovette cader vittima della tipica politica aggressiva di Hitler, deve essere liberato dal dominio tedesco„, non è possibile in questa sede procedere ad un’analisi compiuta della sua formazione.
Ciò che invece rileva ai fini della nostra disamina sono gli effetti dell’adozione di questo mito fondativo nella politica austriaca del secondo dopoguerra. Il rifiuto della responsabilità per i crimini, quando non la loro negazione, e la contestuale identificazione di tutti gli austriaci come vittime del nazismo sono posti alla base di quel processo di unificazione nazionale che trova i suoi epiloghi pubblici più significativi sia nella formazione del primo governo Kreisky formato da Spö e Fpö, nel quale entrano quattro ministri ex nazisti, che nell’elezione a capo dello stato di Kurt Waldheim del 1986, la cui emersione del passato nazista già durante la sua campagna elettorale pone progressivamente l’Austria in una situazione critica sulla scena politica internazionale.
A distanza di quasi quarant’anni da quest’ultimo episodio, la storia dell’Austria di oggi racconta di un paese che ha finalmente intrapreso un percorso di rielaborazione del proprio passato. Ma la dimostrazione di come il mito della prima vittima non sia ancora da considerarsi del tutto superato la si deve alle dichiarazioni rilasciate nel febbraio del 2022 dal ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg, che durante un’intervista rilasciata a Zib2, rubrica giornalistica del canale televisivo Orf, riferendosi all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha affermato: “Wir haben doch 1938 am eigenen Leib erlebt, wie es ist, wenn man alleingelassen wird„ (“Noi abbiamo già provato sulla nostra pelle nel 1938 che cosa succede quando si è lasciati soli„).La storia dell’Austria dopo la Seconda guerra mondiale è legata a filo doppio alla storia della minoranza nazionale di lingua tedesca che vive in Alto Adige/Südtirol e della sua tutela.
In esito all’accordo De Gasperi/Gruber del 1946 e dopo 26 anni di lotte non solo politiche, la popolazione sudtirolese ottiene un’autonomia tra le più avanzate al mondo. Il padre riconosciuto di questa autonomia è Silvius Magnago: già autore nel 1940 di una tesi di laurea in lingua italiana alla facoltà di giurisprudenza di Bologna intitolata “I reati contro la razza ed il patrimonio biologico ereditario nella legislazione nazional-socialista„, è volontario della Wehrmacht e opera nell’Est Europa. Tornato in Alto Adige alla fine della guerra, si circonda di altri reduci dell’esercito hitleriano e arriva al vertice del partito di maggioranza assoluta, divenendone il leader incontrastato e portando a casa il famoso Statuto di autonomia del 1972. Suo il motto “lei net roglen!„ (“non rimestare il passato„).
È questo che si deve fare, non rimestare il passato?Non credo basti una battuta per codificare i processi memoriali vissuti dalle società. Di “battute e frasi fatte„ sul passato nazista se ne sono sentite per settant’anni anche qui in Germania, penso a quella molto elegante dello storico Ernst Nolte, che a metà degli anni ´80, in una società ancora ampiamente abitata da vecchi nazisti a fine carriera e in un quadro di processi mancati e riflessioni obliate lamentava come quello nazista fosse “un passato che non passa più„ (eine Vergangenhiet, die nicht vergehen will). Che lo si voglia o no la riflessione sul proprio passato è un processo necessario e continuo e segna la capacità dei popoli di emanciparsi e definirsi come identità collettiva.
Nel 2022 a Bolzano è stata inaugurata la mostra permanente per i cinquant’anni dell’Autonomia. Tra le madri dell’autonomia è citata Viktoria Stadlmayer in quanto “svolse un ruolo fondamentale nelle trattative autonomistiche per conto del Governo regionale del Tirolo„.
Del passato della signora Stadlmayer, però, non si fa alcun cenno.
Divenuta membro del partito nazionalsocialista nel 1938 su sua stessa richiesta in qualità di “Alte Kämpferin„ (“Vecchia combattente„), nel 1941 consegue un dottorato di ricerca a Vienna sotto la guida del professor Heinrich von Srbit, pangermanista e attivo antisemita studioso di storia moderna che nel 1938 ha già salutato l‚ “Anschluss„ (l’annessione dell’Austria al III Reich) come “die Verwirklichung des tausendjährigen Traums der Deutschen„ (“la realizzazione del sogno millenario dei tedeschi„) iscrivendosi contestualmente al partito nazista con la tessera n. 6.104.788. In seguito all’occupazione della provincia altoatesina da parte dell’esercito hitleriano conseguente all’armistizio dell’Italia del 8 settembre 1943, con la creazione della cosiddetta “Alpenvorland„ (“Zona d’operazione delle Prealpi„) Stadlmayer si trasferisce da Innsbruck a Bolzano assumendo la direzione locale di una sezione della “Alpenländischen Forschungsgemeinschaft„ (“Comunità di ricerca sui territori alpini„, Brain-Trust della politica völkisch nazionalsocialista) e collaborando con le autorità naziste in merito alla questione demografica fino alla fine della Seconda guerra mondiale.
Nella notte tra il 15 e il 16 settembre 1943 gli ebrei di Merano vengono catturati con la collaborazione attiva del SOD (Südtiroler Ordnungsdienst, “Servizio d’ordine sudtirolese„ composto da esponenti della popolazione locale di lingua tedesca) e deportati ai campi di sterminio nazisti.
Come si può conciliare la celebrazione permanente del personaggio citato con una vera cultura della memoria, soprattutto riguardo alla Shoah?Devo dire che non conoscevo questa storia e mi lascia tendenzialmente basito.
Purtroppo, si va ad aggiungere ad una miriade di storie di strumentalizzazione e oblio del passato. Il vero problema non è solamente quello della mancata condanna del collaborazionismo fascista o nazista ma innanzitutto l’ingiustizia ripetuta e ricorrente, che forme di rimozione collettiva perpetrano contro le vittime. Nella Germania dell’Ovest furono tantissime le storie di “vecchi combattenti" nazisti rientrati e reinseritisi professionalmente nelle industrie di stato, nella stampa, nella politica, in un momento storico in cui i membri della resistenza o i vecchi dissidenti del sistema nazista venivano spiati e controllati dal governo, e mi riferisco agli anni ‘50 e '60, anche se non dovremmo dimenticare che fino ancora al 1992 in ogni governo della Bundesrepublik vi era stato almeno un iscritto al partito nazista.
Quello che però accadde con il 1989 e la riunificazione fu che il passato tornò a bussare alla porta del presente e l’evidenza della dimensione dei crimini, del peso del collaborazionismo e della chiarezza dell’impianto criminale del nazismo iniziò a generare un bisogno di cesura definitivo, senza remore o sfumature. Il 1989 è la stata la grande occasione per la Bundesrepublik di riabilitare in maniera irreversibile la centralità delle vittime e la condanna del collaborazionismo e del filonazismo. Certo come vediamo, questo non è un antidoto al ritorno di certe tendenze politiche ma genera un messaggio chiaro e i limiti dentro cui il discorso politico si definisce e si deve e può limitare.Tommaso Speccher, dopo il dottorato in Filosofia alla Freie Universität di Berlino, ha insegnato in qualità di libero docente presso le università di Verona, Berlino e Friburgo.
Attualmente lavora come divulgatore, traduttore e ricercatore presso alcune istituzioni museali berlinesi tra cui il Museo ebraico, la Topografia del terrore e La Casa della conferenza di Wannsee.
Tra le sue pubblicazioni, Täter und Opfer. Verbrechen und Stigma im europäisch-jüdischen Kontext (a cura di, con C.S. Dorchain, Königshausen und Neumann 2014) e Die Darstellung des Holocausts in Italien und Deutschland. Erinnerungsarchitektur, Politischer Diskurs und Ethik (Transcript 2016) (dal sito Editori GFL Laterza).
Vive a Berlino da 16 anni, città nella quale ha fondato assieme a Karin Gambaracci Berlincolor, e poi theberlinest.com agenzia turistica e culturale che si occupa di accompagnare gruppi alla scoperta non solo di luoghi e monumenti della capitale tedesca, ma anche del loro significato storico e sociale.(© Luca Marcon - tutti i diritti riservati. Gli altri articoli dell’autore sono reperibili qui)
«La Germania sì che ha fatto…
„La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo“
Nuovo articolo pubblicato il 7 aprile 2024
Schauen wir uns einige…
Schauen wir uns einige meiner Ansicht nach hervorzuhebende Textstellen an (Zitat): „Richiamando la famosa affermazione di Max Weber laddove “sono i valori che intenzionano le azioni„, rimani sempre della tua opinione?“:
kommen wir also von der Geschichte in die Gegenwart: wie steht es mit denen hier in Italien, die bis in die höchste Volksvertretung hinauf HEUTE den faschistischen saluto romano praktizieren - welche müssen deren „valori“ sein?
Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was im Text folgendermaßen beschrieben ist (Zitat): was „geschah, war, dass die Vergangenheit zurückkehrte, um an die Tür der Gegenwart zu klopfen...“: ... und hören wir, hört der Interviewer dieses „Klopfen“ HEUTE & HIER?
Weiter im Text ein Stelle, die Aufmerksamkeit fordert:
„Natürlich ist dies, wie wir sehen, kein Gegenmittel gegen die Rückkehr bestimmter politischer Tendenzen, aber es erzeugt eine klare Botschaft und die Grenzen, innerhalb derer der politische Diskurs definiert wird und begrenzt werden muss und kann“:
Was geschieht mit einem Politiker im deutschen Kulturraum, der die Hand zum Hitlergruß erhebt? ... und was mit einem Politiker, der im italienischen Kulturraum HEUTE den Arm zum faschistischen saluto romano erhebt?
Erkennt der Frager hierin den Unterschied, der etwas mit Aufarbeitung zu tun hat?
.
Wir können heute einer ähnlichen Entwicklung beiwohnen - in Russland. Im Text: „Und hier möchte ich Hannah Arendt zitieren, die in ihrem Interview mit Gaus einfach sagte, dass die Nazis “eine Bande skrupelloser Menschen„ seien, die Propaganda und kollektives Elend als Mittel nutzten, um absolute Macht zu erlangen“:
also ist es eine „Bande skrupelloser Menschen“ oder sind die Russen als Volk von Grund auf Faschisten und böse?
Sobald es Frieden mit Russland gibt, müssen wir dann, dem Interviewer folgend, das gesamte russische Heer und den gesamten Verwaltungsapparat Russlands, der zur Zeit den Angriffskrieg gegen Europa führt, ächten und bannen, viele Millionen wegsperren aus deren Beruf, öffentlichem und privatem Leben?
.
Ich erlaube mir höflich eine Kritik zum Allgemeinen:
der „Frager“ (der nicht wirklich Frager ist) versucht, so meine Meinung, in seinen unüblich langen und Schlüsse vorgebenden „Fragen“ an den Autor seine eigene Sicht in den Vordergrund zu bringen, den Interviewten gleichsam für seine hier öfters vorgetragenen „Lieblingspunkte“ wohl zu instrumentalisieren.
Es empfiehlt sich, so meine Meinung, die Worte des Historikers/Philosophen ohne die Texte des Fragers zu lesen.
In risposta a Schauen wir uns einige… di Peter Gasser
Danke für den Tipp, habe nur…
Danke für den Tipp, habe nur die Antworten gelesen.
In risposta a Schauen wir uns einige… di Peter Gasser
Es geht im Interview um die…
Es geht im Interview um die Aufarbeitung der NS Zeit in Deutschland, Österreich und Südtirol. Die Verweise auf die fehlende Aufarbeitung des Faschismus in Italien und die nicht gelungene Hyperbel nach Russland sind ein sehr schönes Beispiel für das tu quoque Argument, neudeutsch whataboutismus.
In risposta a Es geht im Interview um die… di Ludwig Thoma
Sie versuchen es halt immer…
Sie versuchen es halt immer wieder - allein der Hinweis ist textanalytisch unrichtig, also konstruiert:
ich habe aus dem vorliegenden Text heraus den Bezug zwischen Vergangenheit und Gegenwart hergestellt(„kommen wir also von der Geschichte in die Gegenwart“) und nach dem Heute gefragt.
Textbezogen korrekt und legitim (geschah, war, dass die Vergangenheit zurückkehrte, um an die Tür der Gegenwart zu klopfen..."), den Horizont erweiternd.
Macht aber nichts...
(Ad rem scheut der Autor die Diskussion).
In risposta a Sie versuchen es halt immer… di Peter Gasser
Sie wollen also die erfolgte…
Sie wollen also die erfolgte Aufarbeitung der NS Zeit in Deutschland damit begründen, indem Sie einen Bezug zur Gegenwart in Italien und Russland herstellen, und das wäre dann ad rem, weil es ja aufzeigt, dass die Nazis in D nach 1945 von allen Schaltstellen ferngehalten wurden.
Alles klar.
In risposta a Sie wollen also die erfolgte… di Ludwig Thoma
Das sagen wieder mal Sie, & …
Diese fehlgeleiteten und unschlüssigen Behauptungen sind Ihre Worte, nicht meine.
Daher: behalten Sie diese in Ihrer Verantwortung; die eigenen Worte/Verknüpfungen dem anderen unterschieben ist unseriös, das hatten wir immer wieder, aber Sie „wollen’s“ nicht lassen.
Sie versuchen immer wieder dasselbe toxische Spiel, so meine Meinung, mir bringt dies nichts -
daher: kein Dialog.
In risposta a Das sagen wieder mal Sie, & … di Peter Gasser
Aber "sobald es Frieden in…
Aber „sobald es Frieden in Russland gibt, müssen wir alle Russen ächten“, dürfen Sie dem Interviewten natürlich unterschieben. Voll schlüssig. Alles klar.
In risposta a Schauen wir uns einige… di Peter Gasser
Seit 70 Jahren wird immer…
Seit 70 Jahren wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob wir die Geschichte der Shoah aufgearbeitet haben. Dazu sage ich nein, das ist nicht geschehen. Die Verfolgung der Juden hat tiefe Wurzeln in den vergangenen Jahrhunderten und ist am Anfang des letzten Jahrhunderts von Russland und den USA nach Europa übergeschnappt und hat schließlich im Dritten Reich zum Exzess geführt, ganz grob nacherzählt. Dieses Trauma hat dazu geführt, dass der Blick auf jede andere Tragödie vernebelt wurde. Es ist zum Beispiel nicht einzusehen, dass zwar im Dritten Reich wahrscheinlich 6 Millionen Menschen ermordet wurden, weil sie nicht den Kriterien der Arier entsprachen, aber gleichzeitig die 27 Millionen Menschen, welche in der Sowjetunion ihr Leben im Krieg ließen, keine Erwähnung finden. Der Großteil dieser Menschen waren Russen und ihnen ist es zu verdanken, dass Hitler kapitulieren mußte. Sie waren die eigentlichen Sieger, die Alliierten haben nur einen kleinen Teil beigetragen. Aber das wird inunserer Geschichtsschreibung systematisch verborgen.
So kommt es auch, dass heute wieder in ganz Europa neonazistisches Gedankengut immer mehr akzeptiert wird. Dass die Nato in ihrem Denken und Handeln den Geist der SS-Einheiten immer mehr ähnelt, dass wir im Jahr 2014 in der Ukraine eine neonazistische Regierung an die Macht gebracht haben, in der der Hitlergruß nicht mehr anstößig ist und der Judenverfolger Bandera zum Volksheld gekürt wurde. Ich Frage mich, wo sind denn unsere Proteste, wenn in Kiew der Bürgermeister Klitschko wohlwollend zusieht, wenn in den Straßen Umzüge veranstaltet werden, wo eine grölende Masse Fahnen mit dem Hakenkreuz schwenken und dabei grölen „vertreibt die Deutschen, erschlägt die Russen und hängt die Juden“. Wohlgemerkt schon Jahre vor dem Jahr 2022. Russland kämpft nicht gegen Europa, es hat Jahrzehnte lang um seine Sicherheitsgarantien verhandelt und nichts bekommen. Die Atombomben der Nato wurden Jahr für Jahr immer näher an seine Grenzen gebracht. Als letztes Land sollte nun auch noch die Ukraine der Nato gehören, obwohl viele Politiker in der ganzen Welt gewarnt haben, diesen Schritt zu unterlassen.
Wenn wir die Nazizeit aufgearbeitet hätten, dann würde man nicht ein neonazistisches Regime unterstützen, und schon wieder gegen Russland vorgehen, welches sich wiederum gegen Nazismus wehren muss, wie vor 80 Jahren.
Aber wir unterstützen noch ein Land, welches Nazismus und Faschismus voll übernommen hat. Der Genozid gegen die Palästinenser schreit zum Himmel seit Jahrzehnten, aber es lässt uns kalt. Zur Zeit läuft im Gazastreifen ein Massenmord ab, der das Massaker im Ghetto von Warschau verblassen lässt. Wenn auch nur ein Hauch von Aufarbeitung der Nazizeit geschehen wäre, könnten wir so etwas nie zulassen, aber nein, wir helfen auch noch mit, verweigern die Hilfsgüter und liefern Waffen an den Aggressor.
In risposta a Seit 70 Jahren wird immer… di Robert Rieder Thum
Zitat: “Der Großteil dieser…
Zitat: „Der Großteil dieser Menschen waren Russen und ihnen ist es zu verdanken, dass Hitler kapitulieren mußte. Sie waren die eigentlichen Sieger, die Alliierten haben nur einen kleinen Teil beigetragen“:
das ist wohl nicht ganz zutreffend. Russland gelang der Vorstoß im Osten auch dank Unmengen von Materiallieferungen aus dem Westen und der gleichzeitig eröffneten Front im Westen.
Da jetzt Russland vordergründig als großen Besieger insgesamt des 3. Reiches darzustellen, erscheint historisch nicht korrekt.
Zudem scheint Russland nicht aus der Geschichte gelernt zu haben: heute heißt der imperialistische Eroberer in Europa, der Völker erobern, ausbeuten, vernichten möchte, der neue ‚echte Europäer‘ (neue Arier, wir, der missartete Westen sind minder wertig): Putin.
Putin der Massenmörder.
.
Zitat: „Die Atombomben der Nato wurden Jahr für Jahr immer näher an seine Grenzen gebracht“: an der Grenze gibt es NUR russische Atombomben.
Bitte nennen den Staat, in welchem grenznah zu Russland „ Atombomben der Nato Jahr für Jahr immer näher an seine Grenzen gebracht wurden“.
In risposta a Zitat: “Der Großteil dieser… di Peter Gasser
zitiere: "Russland gelang…
zitiere: „Russland gelang der Vorstoß im Osten auch dank Unmengen von Materiallieferungen aus dem Westen“
Es ist wahr, dass Russland zu dieser Zeit keine Industrienation war und Waffen und Produktionsmittel importieren musste. Diese wurden mit dem Gold aus der Kolyma und durch Zwangsarbeit bezahlt. Die Opfer und Anstrengungen der Russen in dieser Zeit, auch für uns, sind unermesslich.
In risposta a zitiere: "Russland gelang… di richter a
... und heute machen die…
... und heute machen die Russen das alles zunichte:
hunderte von Milliarden müssen in den nächsten Jahren von uns allen für die Verteidigung gegen den Hitler („Putler“) des 21. Jahrhunderts aufgewendet werden, unermesslich der Schaden, den Russland durch tausende von Bomben, Raketen, Drohnen, Marschflugkörper auf Dörfer und Städte anrichtet, der wiederum mit 100ten Milliarden repariert werden muss.
Europäische Dörfer und Städte werden täglich bombardiert, einige geradezu vernichtet, der Blutrausch Putins scheint ohne Grenzen...
In risposta a Seit 70 Jahren wird immer… di Robert Rieder Thum
"Dass die Nato in ihrem…
„Dass die Nato in ihrem Denken und Handeln den Geist der SS-Einheiten immer mehr ähnelt,....“
Das ist schon sehr sehr weit hergeholt. Sie sollten mal mit Menschen sprechen, die SS-Einheiten bei ihrer „Arbeit“ erlebt haben, oder vielleicht ein paar Bücher darüber lesen. Und wenn Sie dann immer noch Ähnlichkeiten zwischen NATO und SS ausmachen können, weiß ich auch nicht mehr weiter.
Intervista interessante che…
Intervista interessante che permette di prendere consapevolezza di dettagli storici che fanno la differenza!
Riguardo alla formazione del…
Riguardo alla formazione del mito fondativo dell’Austria prima vittima del nazismo - la cosiddetta Opferthese - sul sito dell’università di Trieste è disponibile un lavoro dello storico Karl Stuhlpfarrer intitolato:
"L’Austria, prima vittima della Germania di Hitler.
La storia di un mito e il suo significato"
https://www.openstarts.units.it/server/api/core/bitstreams/c538d7d5-505…
Südtirol ist Italien oder…
Südtirol ist Italien oder besser gesagt, Italien ist leider Südtirol, wenn es um die Aufarbeitung geht.
Den „bösen Deutschen“ wird die Schuld am hiesigen Holocaust zugeschoben, aber die Ausführer waren die SOD, und sie wurde von Südtirolern geleitet. Wo wurde hier aufgearbeitet? Bitte sagen Sie mir.
Durnwalder ging am Tag der Erinnerung ostentativ Karten spielen. Zutiefst beleidigend.
Vielen in meiner Generation sind die Geschichten der Soldaten, die in Russland gekämpft haben, bekannt. Die Berichte über Südtiroler Soldaten, die auf russische Zivilisten geschossen haben, sind noch in meiner Erinnerung. Kriegsverbrecher oder Soldaten, die unmenschlichen Befehlen willig gehorcht haben? Wo ist hier die Aufarbeitung?
Ich könnte Ihnen noch mehrere Beispiele nennen.