Un premio che alimenta il dibattito

-
È partita la fase calda del Premio Architettura Alto Adige 2026. Fino al 15 giugno è stato possibile presentare progetti architettonici appartenenti alle categorie Pubblico, Residenze, Turismo e lavoro, Spazi aperti, paesaggi e infrastrutture, Interni, Riqualificazione dell’esistente e Architettura giovane. Ora è compito della giuria, composta da Anna Popelka, Katharina Volgger e Matteo Motti, giudicare i progetti.
Matteo Motti è Architetto e Urbanista, docente a contratto presso il Politecnico di Milano. Nell’intervista spiega l’importanza del Premio Architettura Alto Adige.
-
Buon pomeriggio, Prof. Motti! Per iniziare, potrebbe spiegare che cos'è esattamente il Premio Architettura Alto Adige?
Certo! Il Premio Architettura Alto Adige è promosso dalla Fondazione Architettura Alto Adige e intende premiare le migliori architetture realizzate nei territori altoatesini. Il premio celebra le opere che sanno dialogare in modo armonioso con il contesto e il paesaggio unendo qualità estetica, sostenibilità e attenzione sociale. Quindi si tratta di valorizzare quei progetti che sono stati realizzati negli ultimi anni e che sono in grado di essere punti di riferimento per il dibattito dell’architettura regionale, ma anche nazionale. Ovviamente, l’ambizione è quella di rapportarsi ad un dibattito culturale nazionale, ma forse anche europeo. Perché no?
-
Quindi è questo il senso del premio: dare un riconoscimento e aprire il dialogo?
Sì, direi che il senso del premio ovviamente è quello di riconoscere le opere di maggiore qualità. Ma forse il senso ancora più importante è quello di alimentare il dibattito sull’architettura contemporanea. Oltre a selezionare i progetti in grado di interpretare le sfide e i temi della contemporaneità, il premio apre proprio un dibattito su quali sono i temi rilevanti su cui le architette e gli architetti si devono interrogare. Come, per esempio, la specificità dei luoghi e dei contesti e come interpretarli. Questo riguarda soprattutto i contesti dell’Alto Adige, come d’altronde tutti i contesti alpini. Sono tutti contesti con un background culturale molto denso ed interessante. Quindi si tratta di guardare come la contemporaneità nell’architettura riesca a legarsi alle specificità territoriali. Poi, credo che un altro tema sia quello dell’originalità del linguaggio architettonico e di come, appunto, l’architettura è intesa non solo come materia edilizia. Ma come arte trasversale che crea luoghi per la socialità, per abitare, per vivere, per lavorare. Infatti, le categorie del premio sono varie e riflettono su questo.
-
Lei come vede l’architettura in Alto Adige?
La qualità dei progetti architettonici in Alto Adige è molto elevata rispetto ad altri contesti italiani. Vedo molto più vicino l’Alto Adige alla Svizzera, per esempio, dove la qualità dell’architettura è diffusa e molto alta. Quindi anche per noi della giuria è molto difficile selezionare 4-5 progetti per ogni categoria, soprattutto se andassimo solamente a valutare la qualità architettonica. Diciamo che il premio serve anche ad alzare l’asticella, cercando di premiare quei progetti che riescono a fare di più, a buttare il cuore oltre l’ostacolo, a diventare pionieri e a trovare nuove frontiere dell’architettura.
-
Lei è l’unica persona di madrelingua italiana nella giuria. Questo influisce sulla Sua percezione dell’architettura altoatesina?
Io sono di Milano quindi vengo da un contesto metropolitano. Lo sguardo di chi non vive una determinato contesto è sempre molto utile perchè sicuramente è più sensibile rispetto ad alcune questioni che potrebbero essere scontate per chi quei contesti li vive tutti i giorni. Ho trovato nell’Architettura altoatesina un’attenzione al patrimonio naturale, culturale e architettonico che in altri contesti non c'è. Lavorare in un contesto vallivo e montano come quello dell’Alto Adige significa dover relazionarsi non solo all’architettura, ma anche al territorio, al paesaggio, alla natura. È molto interessante per me vedere come questi temi vengono interpretati dagli architetti e dalle architette locali. Per esempio come vengono interpretati nei piccoli villaggi rurali. I progetti che troviamo lì sono molto diversi dai progetti che troviamo in una città a fondovalle, come Bolzano. E sono anche diversi dai rifugi alpini sopra i 2,000 metri di altitudine. Quindi, ci sono tanti temi architettonici che a Milano non potrebbero mai esistere. Questa varietà è data dal contesto geografico e territoriale che è così ricco e diversificato. Questa è la cosa che più mi affascina del contesto altoatesino.
-
I risultati del Premio Architettura Alto Adige 2026:
Nell’autunno 2025 la giuria sceglierà a maggioranza e con decisione inoppugnabile i finalisti e i premiati. I finalisti saranno annunciati e pubblicati tempestivamente.
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione avverranno in un contesto ufficiale, durante la Festa dell’Architettura che si terrà il 6 marzo 2026 a Castel Mareccio. Inoltre, in una edizione speciale della rivista Turris Babel saranno pubblicati i progetti selezionati e i premiati.
-
Oltre a essere architetto, Lei è anche urbanista. Anche questo influisce sulla Sua percezione?
Decisamente sì! Ovviamente i temi legati al territorio sono temi che a me interessano molto. Soprattutto il modo in cui piccoli oggetti architettonici possano parlare al territorio e possano relazionarsi a sistemi di scala più vasta. Sicuramente il mio sguardo da urbanista è uno sguardo che cerca di mettere in relazione le architetture ai contesti di riferimento. Io non guardo solo l’oggetto in sé, al linguaggio architettonico, alla cura dei dettagli, ma cerco anche di capirne la dimensione sociale, culturale e geografica.
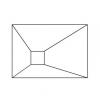

Acconsenti per leggere i commenti o per commentare tu stesso. Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento.