Le due facce della memoria del Vajont
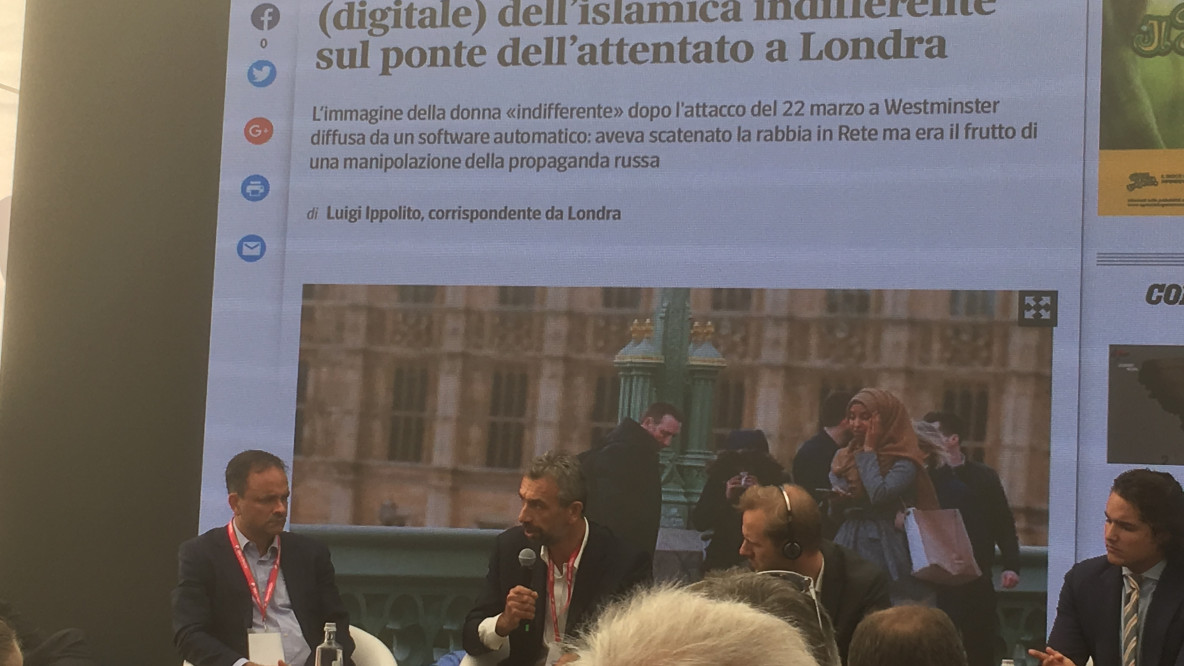
E' stato uno spettacolo teatrale del 1997, interpretato da Marco Paolini e trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, a riportare alla memoria degli italiani uno dei fatti più tragici della storia del nostro paese. Una strage, quella del Vajont, figlia di incompetenze, irresponsabilità e avidità. Una tragedia che è il frutto anche di una cattiva politica e del fanatismo di qualche ingegnere. Ma, a 45 anni di distanza, non siamo tornati sul Vajont a cercare i responsabili di quella tragedia, ma a tentare di comprendere quale memoria sia stata trasmessa.
Sul posto, a Longarone e ad Erto, abbiamo trovate due memorie diverse, due differenti testimonianze che abbiamo identificato nel cimitero monumentale di Fortogna, ricostruito cinque anni fa e dedicato alle vittime del 9 ottobre, e il centro storico di Erto, in gran parte rimasto identico al 10 ottobre del 1963, il giorno dopo la strage del Vajont. Una Pompei di 40 anni fa.
Il cimitero monumentale delle vittime del Vajont a Fortogna
Entriamo dai cancelli laterali, l’ingresso è occupato dagli operai che stanno sistemando il cimitero monumentale in vista del 45esimo anniversario. Stanno lucidando il pavimento, mentre fuori, tra i cippi, c‘è chi tosa l’erba e chi pulisce la chiesetta e la strada di accesso. Ma non sono gli addetti alle pulizie a stonare in questo cimitero composto da 1910 cippi marmorei bianchi. E’ l’emozione che trasmette, o meglio che non trasmette. Sui cippi i nomi delle vittime sono scritti in caratteri bianchi su fondo bianco. L’immagine di insieme trasmette una fredda malinconia. Appare come un ordinato giardino per i morti, ma ai vivi comunica pochissimo.
Potrebbe essere una questione di gusti, se non fosse che il nuovo cimitero è stato costruito nel 2003 su quello vecchio, quello che ospitava le lapidi con le foto delle vittime e con i fiori.
Sui nuovi cippi le foto non possono essere messe, non si possono lasciare dei fiori. Chi per più di quarant’anni era andata sulla tomba del padre o del fratello, cambiando i fiori, parlando all’immagine sulla lapide, ora non può più farlo.
Per questo Micaela Coletti, presidente del “Comitato per i sopravvissuti del Vajont” dice che il nuovo cimitero “nega ai morti l’amore dei vivi”.
“Ci era stato detto che sarebbe stato ristrutturato. L’hanno comunicato attaccando un annuncio sui bidoni dell’immondizia fuori dal cimitero, Ma non è stata una ristrutturazione. Hanno stravolto tutto”.
Tutti i cippi sono uguali, tutti sono “intoccabili”. Certo la morte è una “livella”, di fronte alla morte siamo tutti uguali, ma non di fronte ai propri cari. La tomba del genitore o del proprio figlio non può essere uguale a quella di uno sconosciuto. I cimiteri di guerra sono tutti uguali perché i parenti delle vittime sono lontani, perché vengono costruiti nel luogo della battaglia. Ma il vecchio cimitero era composto da foto, fiori e lapidi scelte e pagate dai familiari. Con le ruspe hanno spazzato via tutto, quarant’anni di memoria, di emozioni, di affetti.
Ma per Micaela il nuovo cimitero è anche un falso storico. “Ora ci sono i 1910 cippi con i nomi, ma nel 1963 furono ritrovati i corpi di meno della metà delle vittime e settecento corpi non sono stati riconosciuti. Il vecchio cimitero, con questa distesa di croci bianche senza nome, mostrava l’enormità della tragedia. Ora hanno messo a tutti un cippo con un nome, ma alla maggioranza di quei cippi non corrisponde un corpo. Anche perché sopra le tombe sono passati con le ruspe. E le foto mostrano come non abbiano utilizzato palette e corde per riconoscere i corpi”.
Micaela, alle 22.39 del 9 ottobre 1963, quando Longarone venne sepolta da una massa di acqua e fango, stava dormendo quando ha sentito un tuono e la voce di sua nonna che diceva di chiudere le imposte perché pensava all’arrivo di un temporale. Poi come ogni temporale che si rispetti, è arrivato il vento, ma fuori era sereno e un vento così forte non si era mai sentito. In un attimo il letto su cui dormiva ha preso il volo “ una forza spaventosa che mi prendeva alla schiena, mi piegava in due, mi schiacciava; la sensazione di essere di gomma, di allargarmi e poi restringermi. Una pressione enorme che mi tirava per i capelli, che mi risucchiava in un pozzo senza fine. Poi, con tanta fatica, ho alzato un braccio, mi sono toccata la faccia cercando gli occhi, il naso, la bocca; mi sembrava di essere diventata sottile, schiacciata, senza spessore; ho alzato le braccia sopra la testa, cercavo qualcosa da toccare, poi il nero. Nero totale”.
Fino a che non sono arrivati i soccorritori a estrarla dalle macerie della casa. Ma si può dire che Micaela sia uscita definitivamente da quelle macerie solo il trentaquattro anni dopo, nel 1997, quando Rai Due ha trasmesso in diretta lo spettacolo di Marco Paolini sulla tragedia del Vajont.
“Ero in cucina a lavare i piatti, quando i miei figli mi hanno chiamato per dirmi che in televisione parlavano di Longarone. All’inizio mi sono chiesta chi fosse quell’attore che parlava del Vajont, cosa poteva saperne lui. Poi mi sono ritrovata a bocca aperta, perché solo allora ho compreso che cosa mi era successo. Ero io a non sapere. Fino ad allora il ricordo era vago. Quel lutto, in cui avevo perso la mia famiglia, avevo dovuto rimuoverlo. A scuola qualcuno ci etichettava addirittura come ‘quelli che vendevano i morti per soldi’. Poi la farsa di un processo, tenuto a L’Aquila, dove in pochi potevano andare. Sono persino arrivata a negare di essere di Longarone. Questo, fino allo spettacolo di Marco Paolini…”.
Micaela avrà raccontato di quello che le è capitato decine di volte e sembra raccontarlo senza particolari emozioni. Solo quando descrive le visite al cimitero monumentale, il groppo le sale in gola, lì dove si annodano rabbia e commozione. “Il nuovo cimitero mi ha rubato nuovamente la memoria. Io vedendo le foto delle altre tombe ricordavo i miei compagni di classe, i miei amici, mi aiutava a recuperare la memoria. Per 40 anni, ho portato fiori e ho parlato alla foto di mio padre in un posto preciso, a cui ero legata. Ora invece mi ritrovo a sbagliare fila e fatico a orientarmi. In un cimitero in cui non si possono portare fiori perché sporcano”.
Erto
Erto ha una storia molto diversa da Longarone. Quest’ultima, che sorge sotto la diga, non ha vissuto le lotte contro la Sade negli anni della costruzione della diga. A Erto e Casso invece, si sono fatte perché era una questione di sopravvivenza.
Da Longarone, la diga è solo un angolo di muro tra due montagne lontane un paio di chilometri. Erto e Casso invece, sorgevano sulla riga destra del Vajont, era il loro torrente quello che veniva imbrigliato dalla diga, furono i loro pascoli ad essere spostati oltre un lago e a franarvi dentro in quella sera di ottobre del '63. Non solo, a Longarone è stato difficile trasmettere la memoria perché i sopravvissuti sono stati pochi. A Erto invece, in molti hanno potuto raccontare come sono andate le cose, come si è stati derubati prima dell’acqua, poi della terra.
A quarantacinque anni di distanza, percorrere le strade del centro storico di Erto, soprattutto in una grigia giornata autunnale, fa pesare l’intera diga sulla nuca di chi passeggia. Si sente solo il rumore dei propri passi tra decine di case cadenti. Bellissime ma inutilizzate.
I pochi edifici restaurati ed abitati, i cani che abbaiano, una stalla, un pollaio, tutto rimanda comunque all’ottobre del 1963. Perché sottolineano una mancanza. Dove sono finiti tutti gli altri?
Erto, al contrario del nuovo cimitero monumentale di Longarone, scatena domande, fa urlare la memoria. Non è ordinato, non è confezionato, è genuino.
Eppure la cittadina friuliana fu solo sfiorata dall’ondata, è Longarone che venne seppellita dal fango. Nonostante questo, il 10 ottobre, il giorno dopo la tragedia l’esercito fece sgombrare tutti gli abitanti. Oggi, tra le strade vuote di Erto è impossibile non comprendere quanta rabbia, quanta sofferenza abbia potuto patire chi per mesi aveva denunciato il rischio della frana, e che, una volta che le peggiori previsioni si sono avverate, venne premiato con una deportazione. Nel 1963 quasi mille persone risiedevano a Erto, ora ci vivono solo una ventina di famiglie.
Quelle decrepite case mostrano oggi un mondo che non c'è più, ma un mondo che vorrebbe tornare a vivere nonostante le difficoltà. Italo Filippin, fa parte dell’Associazione superstiti del Vajont, ma è stato prima commissario, poi sindaco e assessore del Comune di Erto-Casso.
“Hanno tentato di fare sparire la nostra comunità, ma non ci sono riusciti. Nell’ottobre del 1963 siamo stati evacuati e depositati nelle mani della carità pubblica. Hanno spinto molti di noi ad emigrare in pianura ma non tutti hanno accettato. Qualcuno è dovuto andare a vivere a Vajont, una cittadina senza territorio, un posto allucinante, slegata dalla terra su cui sorge. Ma molti non si sono rassegnati”.
In effetti non si possono promettere mari e monti per convincere qualcuno a vivere in pianura. I monti, gli ertani, li avevano già e a dire il vero avevano anche le case.
“Le lotte per tornare nella vecchia Erto sono durate anni. Nel 1972 alcune famiglie sono riuscite a rientrare nelle loro case, ma c’era tutto da risistemare e andava fatto a proprie spese. Purtroppo, ancora oggi questa storia è poco raccontata. Molti sanno cosa è successo nel 1963 ma non conoscono le sofferenze e i magoni ingoiati dopo il disastro. Solo oggi a più di quarant’anni di distanza si comprende quale patrimonio nascondano quelle case abbandonate. Per decenni non è stata stanziato un solo soldo pubblico per il recupero del vecchio centro abitato. Anni in cui gli ertani hanno scritto una grande pagina di resistenza. La valle del Vajont è unica, non solo per quello che è accaduto nell’ottobre del 1963, anche per le sue caratteristiche naturalistiche. Per perservare questa storia occorrono risorse, ma grazie a queste lotte qualcosa sta cambiando”.
(Questi pezzi sono stati pubblicati nel 2008 su una testata online che ha cessato le pubblicazioni)
So nah und doch so fern
Schön, dass es in Südtirol doch Menschen gibt, die Interesse und Anteilnahme zeigen und es nicht bei den üblichen Floskeln belassen. Toller Beitrag!