„Riprenderci gli spazi della scuola“

-
SALTO: Da rappresentanti d’istituto, a fine ottobre avete organizzato un evento di tre giorni al liceo E. Torricelli per discutere di ciò che stava — e sta — succedendo in Palestina. Com‚è nata questa iniziativa?
Pietro Marchi: È nata da un bisogno personale di attivarci di fronte a un tema enorme e tragico, davanti al quale ci sentivamo impotenti. Non volevamo rimanere in silenzio, ma fare qualcosa nel nostro piccolo, all’interno della scuola che rappresentiamo. Da qui sono nati tre pomeriggi di incontri in cui abbiamo affrontato la questione israelo-palestinese da diversi punti di vista: storico, religioso, culturale e naturalmente attuale. Non erigerci a giudici di un momento storico, ma essere giovani ascoltatori che si confrontano, anche su domande come: „Cosa significa la parola ‘pace‚ oggi?“
Prima dell’evento, a scuola si parlava già di questi temi?
Luca Pompili: Qualche professore, in modo isolato, sicuramente ne parlava. Ma mancava un percorso comune o un tentativo coordinato di fare sensibilizzazione. La nostra idea non è stata quella di fare una manifestazione o un corteo, ma un’attività extrascolastica dove gli studenti potessero avvicinarsi a un tema complesso che spesso sembra lontanissimo. Alcuni di noi si interessavano già alla situazione e leggevano molto, quindi abbiamo portato la proposta all’Assemblea d’Istituto dove gli studenti hanno risposto con grande interesse.
„Cosa significa la parola ‘pace' oggi?“
-
L’evento si è svolto nel pomeriggio, fuori dall’orario scolastico. Com‚è andata la partecipazione?
Pietro: È stata minore rispetto a quella annunciata, ma comunque superiore a quello che, onestamente, mi aspettavo. Vista la disaffezione sociale che spesso colpisce la nostra generazione, e la tendenza di allontanarci da ciò che ci colpisce emotivamente, io partivo dall’idea che sarei rimasto in una sala vuota. Invece alcune persone fra docenti, studenti e studentesse hanno voluto esserci.
Il nostro obiettivo era smuovere qualcosa, anche solo portare un po‘ di umanità dentro un contesto in cui spesso si parla di numeri, non di vite. Anche la guerra, nei nostri discorsi, è spesso un capitolo di storia lontano nel tempo e nello spazio quando invece nella nostra quotidianità è „presente“.
Luca: Non credo ci sia disaffezione verso le tematiche in sé. Se apriamo Instagram, vediamo decine di storie e articoli condivisi con posizioni anche critiche. L’inghippo arriva quando bisogna andare oltre quei due minuti di lettura online. Quando devi „sacrificare“ un tempo più lungo per ascoltare e confrontarti davvero.
Qual è stato il riscontro di chi ha partecipato?
Pietro: È stato molto positivo, da parte di studenti, docenti e anche della direzione. Da anni non si organizzava qualcosa di simile, quindi non sapevamo cosa aspettarci. Abbiamo ricevuto molti ringraziamenti, anche inaspettati.
Luca: Ci hanno chiesto se organizzeremo altri incontri, sia sulla Palestina sia su altri temi legati all’educazione civica. Perché quello che viene proposto a scuola come „educazione civica“ non sempre coincide con ciò di cui sentiamo davvero il bisogno.
-
„Difendiamo il diritto di protestare“
Pietro Marchi e Luca Pompili frequentano la quinta del liceo scientifico E. Torricelli. Per loro questo è l’ultimo anno di scuola, e sentono il dispiacere per le uscite didattiche cancellate e per alcuni progetti che non si sono potuti realizzare a causa delle proteste delle e dei docenti.
Ribadiscono però che questo rammarico non è una critica alla scelta degli insegnanti: „Capire le ragioni delle proteste è importante, e difendiamo il diritto di protestare“ dice Luca. Allo stesso tempo ricordano che la scuola non può diventare solo essenziale: „Se la scuola deve essere essenziale, allora faccio gli esami da privatista. La scuola è bella proprio perché è molto di più della didattica.“
-
Tra gli ospiti c’erano figure note, come il giornalista Fabio Scuto, l’eurodeputata Benedetta Scuderi, il senatore Marco Croatti, il consigliere regionale Paolo Romano e l’ex prete missionario Giuseppe Morotti. Quali interventi vi hanno colpito di più?
Luca: È difficile scegliere, perché ogni intervento aveva un focus diverso. Personalmente sono rimasto molto colpito dalla testimonianza di Giuseppe Morotti. Non è mai stato in Palestina, ma ha vissuto anni come missionario al confine tra Iran e Iraq. Ci ha raccontato cosa significa vivere sotto le bombe, non sapere se domani tu ci sarai ancora o dove sarà la persona accanto a te, cosa vuol dire essere esiliati dal proprio Paese. In quelle parole abbiamo rivisto le vite di tanti palestinesi. Sentirlo raccontare con quella calma e quella profondità mi ha colpito davvero.
„Ci ha raccontato cosa significa vivere sotto le bombe.“
Pietro: Io invece sono rimasto colpito dall’intervento di Paolo Romano che ci ha raccontato dell’imbarco sulla Global Sumud Flotilla, dell’arresto da parte delle forze militari israeliane e delle due notti passate in carcere in Israele. In cella, costruita per otto persone ma occupata da venti, è caduto dal letto alle tre di notte, dopo l’ennesimo sopruso delle guardie. È lì, in quel momento, che ha trovato un momento di fratellanza fortissimo con un medico turco conosciuto poche ore prima.
Luca: Paolo Romano ha raccontato che parlavano della „Divina Commedia“ in cella. In queste ore trascorse a parlare di Dante tutto il resto era sparito, erano rimasti solo loro due. Questa testimonianza, che ricorda anche quella di Primo Levi, dimostra che la cultura può servire anche a questo: a rimanere persone negli ambienti in cui la nostra umanità vuole essere cancellata. Per noi che frequentiamo un liceo, dove spesso magari ci chiediamo a cosa servono le cose che studiamo durante le ore di latino o italiano, è stato un messaggio molto bello.
Com‚è stato partecipare all’evento sapendo che l’avete organizzato voi?
Pietro: Mi ha riempito e mi ha fatto bene. Non cancella quel senso di colpa che provo verso una situazione così ingiusta, in cui siamo „coinvolti“ anche solo per il silenzio, perché come dice sempre Luca citando De André …
Luca: … „Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti“. Organizzare questo evento però è stato un modo per non rimanere solo spettatori.
E quali sono state le difficoltà nell’organizzarlo?
Luca: In Alto Adige siamo in un contesto particolare. A Roma ogni due giorni viene occupata una scuola; qui, l’ultima volta che è successo è quando c’era Alexander Langer come professore. Gli studenti, per responsabilità loro o del sistema, sono spesso più passivi. Quindi portare un’iniziativa del genere, che si è svolta in modo non violento e senza interrompere le lezioni, ha richiesto un grande impegno, anche burocratico. Abbiamo la fortuna di lavorare bene con docenti e dirigenza, ma è stato comunque un lavoro enorme. Trovarci poi lì, con un senatore, un’eurodeputata, un giornalista … che confermano la loro presenza, però è stata una grande soddisfazione. Non ce lo aspettavamo.
Come avete scelto le persone da invitare?
Pietro: Ci siamo presi alcuni pomeriggi per fare una bella ricerca e poi abbiamo fatto un po‘ a tentoni. Abbiamo detto: tanto non ci risponderanno, quindi noi mandiamo. E invece nel giro di qualche giorno molti si sono messi a disposizione. In quel processo abbiamo sentito la scuola tornare nostra, non solo un luogo da vivere passivamente. È stato bello riprendere quegli spazi che sono vivi grazie a noi studenti.
Luca: È stato un lavoro quasi totalmente autonomo. I docenti ci hanno aiutato dal punto di vista burocratico e qualche consiglio ce l’hanno dato… consigli che poi non abbiamo quasi seguito (ride). Ma l’organizzazione, davvero, è stata nostra al 99 percento.
„È stato bello riprendere quegli spazi che sono vivi grazie a noi studenti.“
A proposito di riappropriarsi degli spazi: i*le docenti del Torricelli aderiscono alle proteste avviate da vari gruppi di insegnanti quest’anno, cancellando progetti e uscite didattiche. Questo vi ha dato nuovi spazi?
Pietro: All’inizio volevamo solo attivarci sul tema. Poi ci siamo resi conto che questa iniziativa poteva diventare uno spunto per l’educazione civica, che quest’anno è stata ridotta a causa delle proteste. È stata un’opportunità per costruire qualcosa che ci interessava davvero, che poi poteva essere utilizzato anche per un esame o un confronto in classe. La nostra docente di biologia e scienze, per esempio, oltre a partecipare agli incontri, ci ha fatto fare un progetto in classe sul tema del consumo idrogeologico e dell’inquinamento che avviene tramite le bombe e le armi nel Medio Oriente.
Luca: E la prof d’italiano ci ha fatto confrontare autori italiani e palestinesi sui temi dell’esilio e della patria. Non era nostro intento reagire a quello che viene chiamato „essenzializzazione didattica“, ma abbiamo comunque dimostrato che l’educazione civica non è una perdita di tempo per noi, ma qualcosa di importante. E che, se non viene fatta in orario scolastico, ce la organizziamo nel nostro tempo libero.
-
Per preparare un evento del genere c’era bisogno di informarvi molto bene sulla tematica. Da studenti di quinta superiore in tempi dominati dai Social, come vi informate?
Luca: Capita di vedere prima la notizia sui Social perché magari uno apre Instagram la mattina e non il giornale. Ma poi cerco di approfondire e diversificare le fonti il più possibile. Sui social vediamo sempre la stessa minestra che ci viene riproposta, quello che già ci piace. Ma penso che confrontarsi con opinioni opposte sia un esercizio da difendere.
Pietro: A me il giornalismo interessa molto. Infatti l’intervento del giornalista Fabio Scuto è stato interessantissimo. Gli ho chiesto in diretta com’era cambiato il giornalismo sul tema della violenza negli ultimi anni. Ci ha risposto che il giornalismo ormai è una macchina economica come altre e che quindi occorre essere attentissimi alle fonti, ma anche mantenere un’attenzione morale alta e un pensiero critico di fronte a ciò che stiamo leggendo.
„Magari apro Instagram la mattina e non il giornale, ma poi cerco di approfondire e diversificare le fonti il più possibile.“
I giornalisti dovrebbero investire di più su piattaforme come TikTok per raggiungere la vostra generazione? Che consigli date ai giornalisti e alle giornaliste in Sudtirolo?
Pietro: Io non ho TikTok.
Luca: Neanche io. Però è vero che il giornalismo è un’arte che sta scomparendo: conosco veramente poche persone che leggono i giornali e hanno meno di 25 anni. Infatti ogni volta che apro la Repubblica mi sento vecchio. Non so come potreste cambiare questa cosa, ma se dovessi dare un consiglio a voi giornalisti: non usate ChatGPT per scrivere articoli, perché… si vede.
Pietro: E vivere il giornalismo non come un lavoro, ma come una passione. So che è una frase un po‚ naïve, ma sarebbe bello se si riuscisse sempre a trovare il perché si sta scrivendo una cosa, anche nell’articolo più banale.
Nel 2022 avete partecipato a un concorso letterario, presentando una storia che parte dai temi e dai valori di Alexander Langer. Da dove nasce il vostro interesse per la politica e la giustizia sociale?
Pietro: È qualcosa che ho appreso dai miei genitori che mi hanno insegnato a essere critico rispetto a ciò che vivo. Credo che la politica faccia parte di ognuno di noi. Dire „non mi interessa“ è come mentirci un po‘, perché politica non significa parlare di partiti, ma di temi che riguardano tutti.
Luca: Si dice sempre „via la politica dalle scuole“, ma ci fa ridere, perché politica significa occuparsi della polis, cioè della comunità, del nostro giardino. Togliere la politica dalle scuole finisce per favorire i partiti, perché se non siamo abituati a ragionare politicamente, facciamo più fatica poi a scegliere chi votare.
„Si dice sempre “via la politica dalle scuole„, ma ci fa ridere...“
L’esperienza fatta con la creazione di questo evento la consigliereste anche ai ragazzi e alle ragazze di altre scuole?
Pietro: Sì. Penso che ogni persona abbia dei temi che le stanno a cuore. E non sto parlando solo di politica e educazione civica. Magari mi interessano gli scacchi, per esempio. Anche qui si potrebbe approfondire. Spesso viviamo la suola come luogo del dovere dal quale allontanarci dopo le lezioni. Ma stare a scuola vuol dire anche avere a disposizione spazi e tempo per occuparmi di quello che mi sta a cuore. E i docenti sono più che contenti di darci una mano quando vedono uno slancio da parte nostra.
Luca: Concordo. So che non è sempre facile vivere la scuola come un ambiente propositivo. Portare avanti un’idea e esporsi richiede anche un po' di coraggio, qualcuno magari si vergogna o ha paura di dire sciocchezze. E probabilmente le dirà. Ma a scuola ci possiamo allenare.
-
Weitere Artikel zum Thema
Gesellschaft | Klassenkämpfe 2Tra parole e pugni
Gesellschaft | Klassenkämpfe 4Schüler stehen am Ende der Nahrungskette
Gesellschaft | Erlebnisbericht/1Das übliche Chaos am Morgen


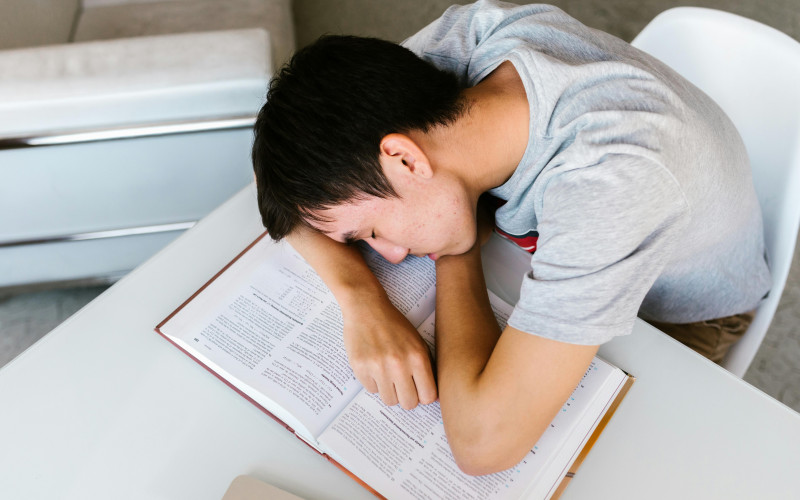

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.