Memoria traumatica

-
L’area che dalle Alpi si spinge sino all’Adriatico è ricca di culture, di lingue ma anche di memorie, memorie collegate a un passato, soprattutto a un ventesimo secolo, che ha lasciato profonde ferite sul territorio e nell’identità delle comunità che lo vivono. Una di queste comunità è quella slovena in Italia, presente lungo tutta l’odierna area di confine fra Italia e Slovenia
Per gli sloveni, come per tutte le popolazioni dell’area, il ventesimo secolo ha portato grandi trasformazioni, con frequenti cambiamenti di confini e di appartenenza statuale. Ma, nello specifico, vi è un periodo storico che ha lasciato ferite particolarmente profonde nella memoria della comunità, quello del ventennio fascista. Un periodo in cui il regime totalitario affermatosi in Italia ebbe in queste aree una caratteristica peculiare: innestandosi su un nazionalismo italiano antislavo già presente giunse prima a teorizzare, e poi a mettere in pratica, l’assimilazione forzata della popolazione slava (slovena e croata) dei territori annessi all’Italia dopo la prima guerra mondiale. Era una volontà di assimilazione forzata fortemente permeata di pregiudizio e razzismo, nella convinzione che gli slavi (termine spesso utilizzato proprio dai fascisti, non particolarmente interessati a distinguere fra sloveni e croati, visti entrambi come ugualmente inferiori) fossero inferiori e andassero quindi assimilati, con le buone o le cattive, alla superiore civiltà italiana. Un’assimilazione fatta di violenza fisica, psicologica e normativa, diventata mano a mano sempre più stringente mentre il fascismo dispiegava liberamente la propria ambizione totalitaria di completo controllo della società italiana.
La distruzione del Narodni dom è il primo dei grandi momenti di sopraffazione della bonifica etnica voluta dal fascismo – sarà il Duce stesso a usare questo termine.
Una memoria così traumatica si esprime anche attraverso dei luoghi, tre di essi meritano un particolare approfondimento. Il primo è il Narodni dom, la Casa nazionale, realizzata nel 1904 nel contesto della Trieste asburgica come punto di riferimento non solo per gli sloveni di Trieste ma per il complesso dei popoli slavi della Monarchia asburgica che trovavano in Trieste il proprio sbocco al mare. Un grande edificio polifunzionale, simbolo di emancipazione e di forte presenza nel centro cittadino e visto come tale come elemento estraneo e inaccettabile da quelle frange maggiormente nazionaliste delle classi dirigenti italiane. Tale ostilità non avrebbe potuto che trovare la sua più forte espressione nei tumultuosi mesi del primo dopoguerra, mesi di forte incertezza e di continui cortocircuiti fra le autorità italiane, appena arrivate sul territorio, e la popolazione slovena e croata nel complesso dell’area. E si arriva così al 13 luglio 1920, un giorno che è un punto di svolta della storia non solo triestina ma anche europea, perché è, purtroppo, una delle prime grandi azioni del fascismo in generale. I fascisti quel giorno assaltano il Narodni dom; e lo distruggono; e se ne vantano. Perché la distruzione di quell’edificio è veramente per il neonato movimento politico una grande impresa; ma è al contempo un grande trauma per chi la subisce, gli sloveni: un trauma raccontato in modo drammaticamente splendido da Boris Pahor, il grande scrittore sloveno triestino e straordinario testimone del XX secolo, che è di quell’assalto testimone oculare, come bambino di sette anni. -
 Newspapers on the Border: Le minoranze in Europa si trovano in situazioni simili a quella della comunità slovena nel Friuli-Venezia Giulia. GO!2025 ha offerto spazio alla conferenza „Minorities: Newspapers on the Border“ per riunire e confrontare diverse esperienze ai confini europei. Foto: Veronika Vascotto/Kulturlemente
Newspapers on the Border: Le minoranze in Europa si trovano in situazioni simili a quella della comunità slovena nel Friuli-Venezia Giulia. GO!2025 ha offerto spazio alla conferenza „Minorities: Newspapers on the Border“ per riunire e confrontare diverse esperienze ai confini europei. Foto: Veronika Vascotto/Kulturlemente -
Quella distruzione rappresenta per gli sloveni l’inizio di una nuova era: un’era di sofferenza e di sopraffazione, che si svilupperà in tutta la sua forza dopo l’ascesa al potere del fascismo nel 1922. La distruzione del Narodni dom è il primo dei grandi momenti di sopraffazione della bonifica etnica voluta dal fascismo – sarà il Duce stesso a usare questo termine. Seguirà la chiusura delle scuole, la modifica dei nomi e cognomi, la volontà di soffocare qualsiasi espressione linguistica e culturale di chi, in questo territorio, non corrispondeva alle aspettative del regime. Fortunatamente la storia di quell’edificio non si conclude con quell’incendio ma si riempie di nuovi capitoli soprattutto negli ultimi anni, in cui lo stato italiano decide di restituire l’edificio – il processo è formalmente già concluso, nei fatti ancora in corso – alla comunità slovena. Il Narodni dom torna così a esser protagonista della storia cittadina, presente e futura; ed è una straordinaria sfida non solo per gli sloveni ma per tutta la città.
Ma le vicende della sopraffazione fascista che ha il suo grande inizio nell’incendio del Narodni dom proseguono negli anni successivi e danno vita a una reazione: nella seconda metà degli anni Venti fra le giovani generazioni slovene e croate inizia a comparire la volontà di opporsi, e poiché l’opposizione legale non è più possibile si passa all’illegalità. È l’atto di nascita delle organizzazioni TIGR (Trst, Istra, Gorica, Reka, ovvero Trieste, Istria, Gorizia, Fiume dai territori in cui si stava sviluppando quest’opposizione) e Borba (Lotta), i cui membri sono noti come „borbaši“. Essi iniziano a sviluppare un’attività clandestina ancora incerta, scoprendo sul campo – e sulla propria pelle – che cosa voglia dire organizzare un movimento di opposizione a un regime totalitario. Si contrabbandano e stampano testi in sloveno, poiché se l’obiettivo fascista è quello di sradicare una secolare presenza culturale e linguistica la prima opposizione non può che essere quella di difendere la lingua; ma iniziano anche azioni più radicali, come per esempio gli incendi degli edifici scolastici. È un tema molto forte e che non può non colpire e che va quindi spiegato e compreso. Quelle scuole erano state realizzate pochi decenni prima, con grandi sacrifici e sforzi, nell’ultimo periodo asburgico, e costituivano per quelle comunità una speranza di emancipazione e di un futuro migliore; ma il fascismo aveva fatto di quegli stessi edifici, sradicando i maestri che quelle comunità avevano prodotto e sostituendoli con altri venuti da fuori, il principale strumento di assimilazione forzata. Quegli edifici, nati per emancipare, erano diventati strumenti di sopraffazione. Da qui la decisione dei giovani militanti sloveni di fare di quegli edifici i propri bersagli, decisione che voleva dire, spesso, appiccare l’incendio a quelle stesse scuole che avevano frequentato pochi anni prima.
-
Ma nella logica di uno stato totalitario la violenza può solo conoscere un’escalation. E alla fine degli anni Venti il fascismo, che ormai dispone di tutti gli strumenti di repressione, invia a Pola, in Istria, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che condanna a morte un giovane croato, Vladimir Gortan. Per i „borbaši“ si tratta di decidere se fermarsi o rilanciare. Scelgono la seconda ipotesi, con attentati dinamitardi al Faro della Vittoria di Trieste, simbolo della vittoria italiana nella Grande Guerra, e alla redazione del quotidiano fascista Il Popolo di Trieste. Quest’ultimo attentato provocherà una vittima, un redattore: sarà l’occasione per i fascisti di scatenare una grande campagna di repressione, che culmina nel primo processo di Trieste del settembre 1930: il tribunale speciale fascista condanna a morte quattro giovani, Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš e Alojz Valenčič, fucilati presso la località carsica di Basovizza-Bazovica all’alba del 6 settembre 1930.
Diventeranno, da subito, degli eroi nella memoria non solo degli sloveni di Trieste, ma degli sloveni in generale.
Fino al 1945 e alla liberazione dal nazifascismo nemmeno il luogo della loro sepoltura sarà noto: solo dopo la fine della guerra si scoprirà l’esatto luogo della sepoltura presso il cimitero di S. Anna, a Trieste, dove oggi un monumento li commemora. Così com‚è c‘è un monumento a ricordarli a Basovizza, in uno dei più importanti luoghi della memoria per i popoli sloveno e croato e si trova a poche centinaia di metri da un altro monumento, quello della Foiba di Basovizza, monumento nazionale che ha ricevuto crescenti attenzioni nel contesto italiano negli ultimi decenni. Per questo è particolarmente significativo che il 13 luglio 2020, mentre si trovavano a Trieste in occasione del centenario dell’incendio del Narodni dom e dell’avvio del processo – ancora in corso – con il quale lo Stato italiano restituiva agli sloveni l’edificio, i presidenti italiano Mattarella e sloveno Pahor si siano recati, mano nella mano, a entrambe le Basovizze, a rendere omaggio a una memoria particolarmente importante per lo stato che rappresentavano e a una memoria importante per lo stato vicino.Esiste però un terzo luogo, simbolicamente legato a doppio filo a Basovizza, che testimonia come il rapporto con il passato in queste terre sia ancora tutt’altro che risolto: è il Poligono di Tiro di Opicina-Opčine, anch’esso sul Carso triestino. In questo luogo il 15 dicembre 1941 altri cinque sloveni – Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič e Ivan Vadnal vengono fucilati dopo la condanna a morte comminata dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato nel Secondo Processo di Trieste. Siamo già in piena seconda guerra mondiale e il nuovo processo, che trae ispirazione da quello del 1930, serve al regime per dare un segnale a tutti gli sloveni – sia nella Venezia Giulia che nell’appena istituita Provincia di Lubiana costituita dopo l’invasione della Jugoslavia. Presso lo stesso Poligono, nell’aprile 1944, i nazisti impadronitisi del territorio dopo la capitolazione italiana del settembre 1943 fucileranno per rappresaglia 72 ostaggi (di cui uno sopravviverà) e quei 71 corpi saranno i primi con i quali verrà testato il funzionamento del forno crematorio della Risiera di San Sabba. Altre esecuzioni si svolgeranno in quel luogo sino all’aprile 1945. Gli sforzi per dare un’adeguata sistemazione a quel luogo della memoria sono ancora lontani dall’aver raggiunto un risultato definitivo: e nel frattempo, sullo sfondo, si sentono ancora gli spari del poligono ancora oggi attivo…
-
Štefan Čok, nato nel 1983 a Trieste, dove ha sempre vissuto, ha ottenuto la laurea specialistica in Storia della Società e della Cultura Contemporanea presso l’Università di Trieste e il dottorato in Storia dell’Europa e del Mediterraneo presso l’Università del Litorale di Koper-Capodistria, in Slovenia. Lavora presso la Sezione di Storia ed Etnografia della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trieste. Si occupa primariamente dei rapporti fra italiani e sloveni nell’area altoadriatica dalla fine del XIX secolo a oggi, con una particolare attenzione alla trasmissione della storia e delle memorie alle giovani generazioni.
INFO: Kulturlemente
-
Weitere Artikel zum Thema
Kultur | GastbeitragJekami
Kultur | Salto WeekendLebensnotwendig wie der Tod
Kultur | salto afternoonMathematik und Wirklichkeit

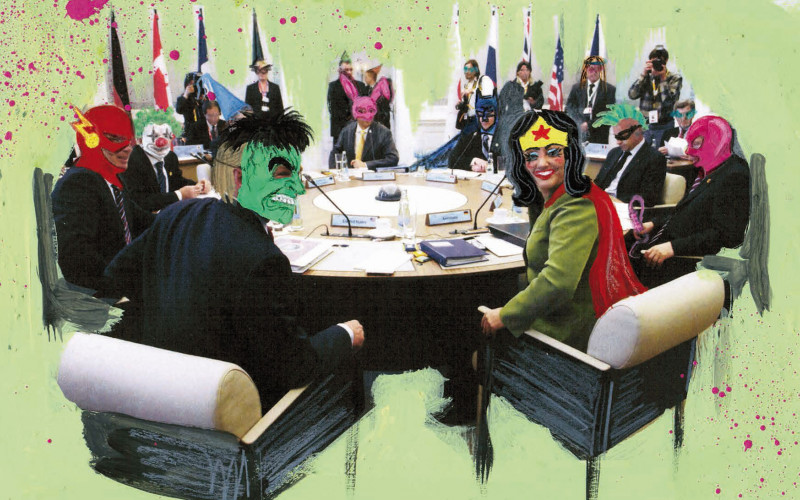


Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.